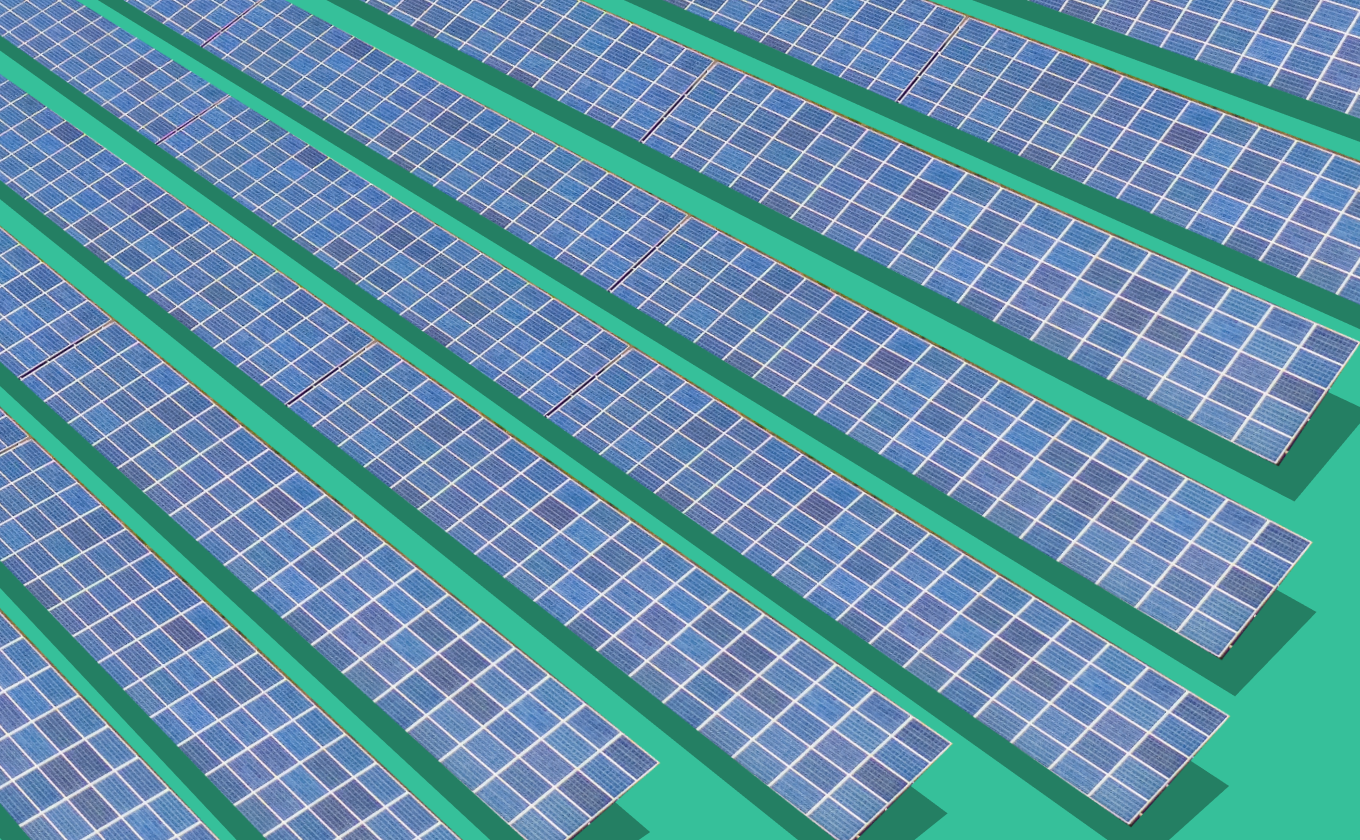Abbiamo cercato la definizione di una fonte letteralmente autorevole del settore, cioè il GSE (il Gestore Servizi Energetici):
“Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.”
Come dicevamo, la comunità mette a disposizione spazi e impianti. La parrocchia di cui parlavamo nell’introduzione, per esempio, ha installato un impianto fotovoltaico da 20 kWp sul tetto della chiesa e ha selezionato alcune famiglie della zona con cui condividere la luce prodotta. Per formare una Comunità energetica, infatti, chi partecipa deve trovarsi in una zona geografica limitata: i vari POD devono essere collegati alla stessa cabina elettrica primaria, cioè il punto della rete nazionale su cui viene distribuita l’energia prodotta dagli altri impianti italiani.
Nel caso di una Comunità energetica, per l’appunto, l’impianto restituisce l’energia a chi partecipa, in questo caso alle otto famiglie della parrocchia della Santa Famiglia di Nazareth. Come dice sempre il GSE, tutta l’energia non utilizzata in autoconsumo – cioè dalle stesse persone che partecipano alla Comunità energetica – può essere venduta a condizioni di mercato. Secondo le previsioni di Don Valeriano Giacomelli, consigliere provinciale della Congregazione di san Luigi Orione dove si trova la parrocchia, a ogni famiglia dovrebbero arrivare circa 180 € all’anno: i numeri precisi ancora non ci sono perché la comunità ha iniziato a produrre energia da agosto 2024. In casi come questi, però, è fondamentale che i consumi delle famiglie non superino l’autoconsumo previsto: solo così potrebbe esserci quel piccolo guadagno che rende le Comunità energetiche tanto interessanti.