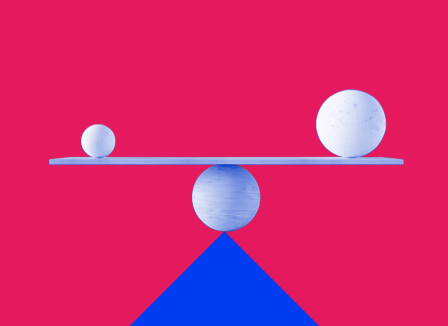È la legge da cui tutto ha avuto inizio. A leggerlo sembra strano dover tornare così indietro nel tempo, ma già nel 1934 l’EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, il nonno della RAI) aveva iniziato a fare i primi esperimenti di trasmissione televisiva. La primissima immagine in movimento era riuscita a viaggiare già nel 1925 grazie a John Logie Baird, le cui apparecchiature permisero alla BBC di nascere già due anni dopo.
Insomma, nel ‘38 la televisione non era certo diffusa e non c’era nessun palinsesto (la programmazione vera e propria partirà nel ‘54) ma era già nata la necessità di regolamentare il possesso – e quindi l’abbonamento a un servizio – di ogni apparecchio radiotelevisivo. Ma cosa dice, quindi, questo decreto? Ecco la citazione che ci interessa:
«Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.»
Tradotto dal non poi così antico burocratese: hai una televisione che può ricevere il segnale televisivo? Allora ti chiederemo un canone per il servizio televisivo, dato che si presuppone guarderai quello che trasmette la tua “scatola di immagini”.
Il decreto del ‘38 è stato poi salvato nel 2010 dal decreto Taglia-Leggi (ebbene sì, il decreto si chiamava proprio così), perché non avrebbe avuto senso abrogarlo.
Questa imposta, infatti, serve proprio a finanziare i programmi della televisione pubblica. Lo Stato la incassa come una normale imposta ma, tolte le tasse che rimangono nelle sue casse, il resto viene usato per finanziare telegiornali, radiogiornali e tutte le trasmissioni a carattere pubblico o di attualità. È questo che rende la RAI un servizio di pubblica utilità. In cambio, la RAI deve rispettare un contratto di servizio che potrebbe essere revocato se violato.